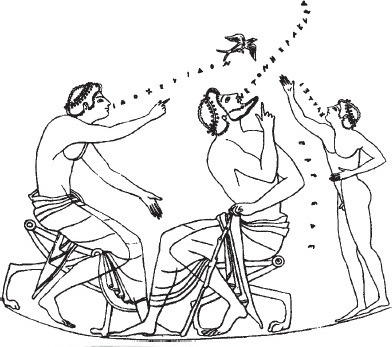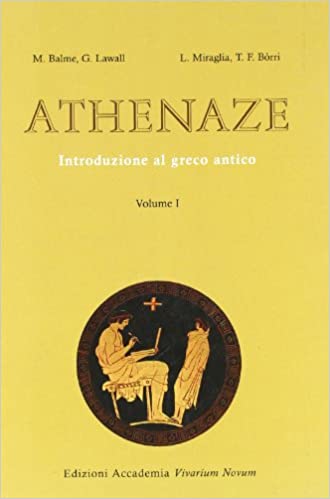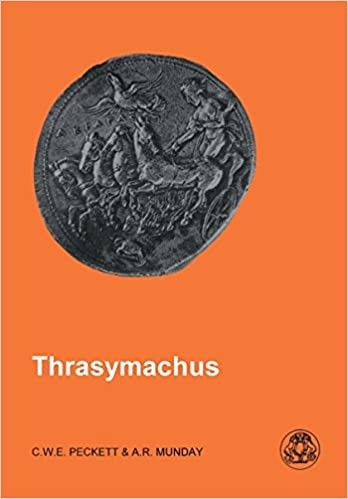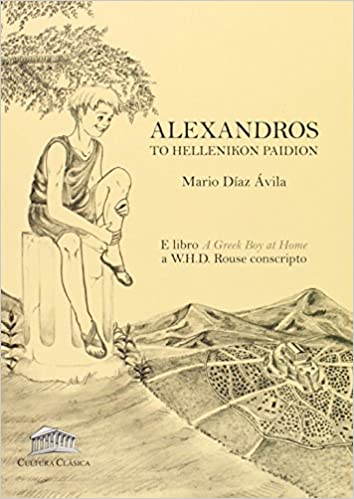Nelle scuole italiane viene generalmente utilizzato un metodo di insegnamento del greco antico che si basa sull’acquisizione delle norme grammaticali e a volte, se va bene, di alcuni vocaboli chiave ma si lascia poi allo studente una sorta di rebus (la versione) che deve essere risolto con un enorme decodificatore che è il dizionario.
In passato, però, il greco veniva insegnato come una vera e propria lingua viva tramite un metodo induttivo che permetteva allo studente di acquisire a tutti gli effetti la lingua. Oggi, anche sulla scia del successo del libro Familia Romana di Hans Henning Ørberg, esistono numerosi libri che permettono di tentare di acquisire il latino con il metodo induttivo da autodidatti o seguendo dei corsi specifici. Troverete nomi diversi per indicare una stessa cosa: greco vivo, con metodo induttivo o “metodo natura”.
Ma qual è lo scopo di imparare il greco in greco? Ovviamente non è iniziare a parlare greco con gli amici, ma imparare le parole più comuni presenti nei testi antichi, saperli distinguere tra loro avendone una effettiva padronanza in modo tale da poter poi leggere la letteratura in lingua e comprendere un buon quantitativo dei testi letti senza l’ausilio del dizionario. Oltre a questo si può dire che, alla fine del quinquennio scolastico, gli studenti avranno effettivamente in mano qualcosa, cosa ce non si può dire per il greco fatto normalmente a scuola che porta, nella maggioranza dei casi, ad un’acquisizione lessicale molto bassa e un rapporto con la letteratura che è sostanzialmente in traduzione.
Il metodo ha dei pro e dei contro in particolare se utilizzato in classe. Prima di tutto non è per nulla scontato che un docente, per quanto esperto di greco, sia in grado di parlare greco alla classe. Non ci si improvvisa insegnanti nel metodo induttivo ma è necessaria una lunga preparazione e abnegazione. Sebbene ci si possa gettare e impararlo da autodidatti, il metodo natura è complesso e sarebbe preferibile seguire dei corsi specifici (ormai ce ne sono diversi anche online, io ad esempio ho seguito, in presenza, quello dell’IISC a Roma). Fare greco vivo non vuol dire leggere e tradurre, ma significa far acquisire, proprio come nelle lingue ancora in uso, il lessico e le strutture sintattiche agli studenti che dovranno poi utilizzarle imparando a ragionare, per quanto possibile, nella lingua di origine. Proprio per questo sarebbe meglio se gli studenti non traducessero affatto almeno per il primo biennio. Un metodo “vivo” applicato male può avere effetti terribili sul livello di acquisizione del greco perché, avendo tempi di acquisizione grammaticali totalmente diversi rispetto a quelli del greco scolastico, si rischia che la classe non impari sostanzialmente nulla e acquisisca un livello di preparazione nella materia molto bassa. Quando il metodo è invece insegnato nella maniera opportuna i docenti e gli studenti potranno togliersi tante soddisfazioni e arrivare ad avere una effettiva padronanza della lingua greca antica.
Per completezza segnalo alcuni contr che penso possano essere utili a chi legge: tenete presente che non tutti i testi in commercio si basano sul lessico frequenziale, ovvero sul numero di parole più utilizzate nei testi antichi, e vi potreste quindi trovarvi a dover affrontare storie con terminologie francamente evitabili. Problematica ben maggiore è la difficoltà di integrare questo metodo all’interno di un sistema scolastico ci cui la didattica non sempre è continua e in cui le ore sono spesso divise in più giorni. Per un’applicazione fruttuosa del metodo, sarebbe infatti meglio avere più ore di seguito, ma questo spesso non è possibile e costringe il docente a dover scegliere se andare avanti col testo o concentrarsi sul ripasso o la verifica di quanto acquisito dagli studenti. Altro problema da non sottovalutare è che il greco, al contrario del latino, è molto diverso dall’italiano e non è sempre scontato far capire agli studenti il significato di determinate parole. Bisogna quindi ingegnarsi molto di più preparando powerpoint interattivi, utilizzando oggetti o mimando le azioni che daranno però vita a situazione del tipo “caccia al significato” che i discenti tradurranno inevitabilmente in italiano.
Attualmente l’unico tradotto in italiano è Athenaze di M. Balme e G. Lawall la cui caratteristica principale è quella di avere una storia organica con gli stessi protagonisti ma ha il difetto dello scoglio iniziale del capitolo 1 che introduce tantissime parole senza dare allo studente il tempo di ambientarsi. Miraglia è intervenuto sul testo per provare a risolvere un minimo il problema, però fare miracoli era decisamente impossibile.
Se Athenaze non vi piace potete provare due alternative: Reading Greek edito da Cambridge University Press che include testi decisamente più ricchi e divertenti ma che non hanno un protagonista unico. Oltre a questo la grammatica, gli esercizi e il dizionarietto sono in inglese. Da qualche tempo il tutto è disponibile anche in ebook. Nel corso degli anni sono stati inoltre pubblicati molti volumi integrativi per potersi esercitare con testi antologici, storico-mitici, filosofici e neotestamentari. Se si vuole studiare da autodidatti il testo principale esiste inoltre un volume apposito da acquistare a parte.
Esiste poi un terzo e meno noto libro che si chiama Thrasymachus di C.W.E. Peckett e Anthony Munday che è sempre disponibile in versione inglese e ha quindi gli stessi problemi di Reading Greek. Ha il vantaggio però di essere un volume unico, avere un personaggio unico e basarsi molto su eventi mitici ed eventi paradigmatici.
Ancora meno strutturato e utile più che altro ad acquisire il lessico troviamo Greek Boy di Rouse che è stato poi rivisto, ampliato e reso più fruibile con la versione spagnola Alexandros: to Hellenikon Paidion di Mario Díaz Ávila. Quest’ultima, rispetto ad Athenaze e altri libri, è totalmente in greco e questo può avere i suoi pregi sotto la guida di un docente esperto. Non c’è una storia strutturata ma tante piccole unità dedicate ad un argomento particolare.
Non consiglio il metodo Polis o Assimil perché si basano su dialoghi spesso legati alla quotidianità contemporanea e sono, a mio avviso, un orpello divertente ma che non portano al risultato di cui parlavamo prima: leggere la letteratura in lingua.